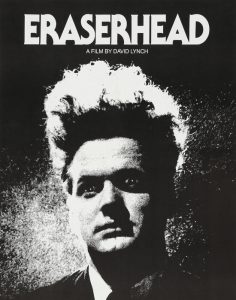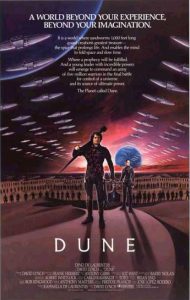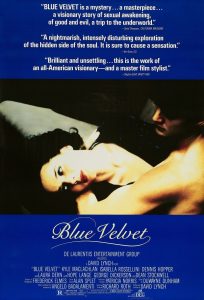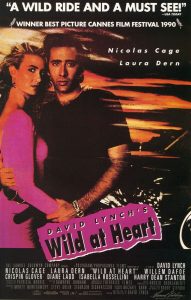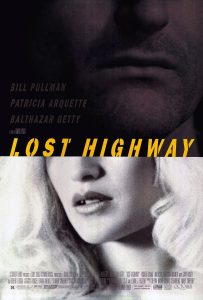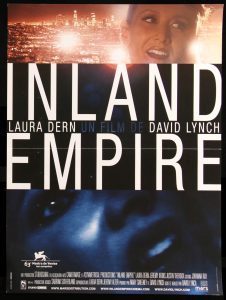Oggi, 21 ottobre, è una data storica per il tennis italiano: si è scoperto che chi osa criticare le decisioni sportive di Jannik Sinner è un “italiano medio” e non capisce nulla di sport (frase edulcorata, ovviamente).
È di ieri la notizia della rinuncia del campione alla Coppa Davis, manifestazione che ci ha fatto vincere per due anni consecutivi e che molto probabilmente perderemo quest’anno. Sinner ha deciso di non partecipare per precauzioni fisiche e per prepararsi al meglio alla prossima stagione, con l’obiettivo di tornare numero uno al mondo in quella che è ormai una lotta meravigliosa con Carlos Alcaraz.
Dispiace, però, constatare il vuoto tecnico e fisico dietro di loro: un vero e proprio deserto tennistico.
Fa sorridere (molto) la reazione dei tifosi, che hanno difeso a spada tratta la scelta dell’ultimo vincitore di Wimbledon. Curioso, perché gli stessi tifosi furono spietati nei confronti di Francesco Acerbi, ex difensore della Reggina, quando qualche mese fa rifiutò la chiamata in nazionale dell’allora ct Luciano Spalletti, con il quale ebbe dei problemi.
Sembra esserci un pizzico di incoerenza tra i due trattamenti… ma sarà sicuramente un’allucinazione mia.
Fa sorridere anche la difesa automatica nei confronti di Sinner quando si parla della sospensione dai campi dovuta a una contaminazione da clostebol (nessuna colpa dell’atleta, sia chiaro: fu una svista del massaggiatore e non incise minimamente sulle prestazioni). Ma il regolamento è chiaro, e vale per tutti.
La federazione infatti si accorse successivamente della falla nel regolamento e dal 2027 (tempi burocratici, purtroppo) chi non supererà una certa soglia di contaminazione o assunzione, soglia che effettivamente intaccherebbe le prestazioni, non verrà punito.
Trovo surreale che qualcuno creda che un atleta – allora primo al mondo – potesse ricevere un trattamento di favore anzitempo solo perché “è il nostro orgoglio nazionale”.
Si può criticare il regolamento, certo, ma negare il problema è ridicolo.
Anche perché, quando Iga Świątek fu sospesa quasi nello stesso periodo per un episodio simile (una confezione di melatonina contaminata acquistata in farmacia), non si sollevò alcuna rivolta popolare. Evidentemente, per indignarsi serve la bandiera giusta.
E poi, fa sempre ridere vedere con quanta veemenza i fan difendano Sinner una settimana dopo averlo visto partecipare a un torneo a Riad, in Arabia Saudita, località famosa per la sua lunghissima tradizione tennistica (ironia, nel caso non fosse chiaro).
Un torneo che non aveva alcun valore ai fini del ranking ATP, ma che, guarda caso, ha riempito di soldi tutti i partecipanti.
Ora, sia chiaro: Sinner lo sportivo è encomiabile. Forse non si è mai visto un atleta con questa intelligenza, questa forza di volontà e soprattutto questa educazione. In un paese pieno di Cassano e Balotelli, Jannik Sinner è una benedizione.
Questo, però, non significa che debba essere immune da ogni critica.
Il vero problema non è lui, ma i suoi tifosi — o meglio, i suoi fanatici.
Quelli che due anni fa probabilmente non sapevano neppure come si impugna una racchetta e oggi si ergono a esperti di fisiologia sportiva, gestione del calendario ATP e marketing tennistico.
Gente che ha tutto il diritto di tifare e gioire, ma che dovrebbe evitare di portare nel tennis gli stessi atteggiamenti da curva sud a cui erano abituati. Perché, sorpresa: non è la stessa cosa e sarebbe Sinner il primo a non volerlo.

Ognuno ha il diritto di pensarla come vuole, ma trovo paradossale che chi esprima un’opinione contraria venga etichettato come “italiano medio”.
E non posso accettare chi osa criticare le dichiarazioni di leggende come Pietrangeli o Panatta, che sia chiaro, nei mesi e anni passati hanno rivolto delle parole pessime nei riguardi del tennista ma è giusto che ogni parola venga contestualizzata e che non si venga tacciato di essere “rosicone” ogni volta solo perché effettivamente hanno dato l’impressione di esserlo in altre occasioni, sennò non potrebbero più parlare.
Mi fa ridere — amaramente — che la tanto rivendicata libertà di parola valga sempre, tranne quando si parla del nostro santo protettore del tennis, Jannik Sinner.
Perché, alla fine, la verità è semplice: non è la scelta di Sinner il problema. È la nostra incapacità di parlarne senza trasformarci in ultras travestiti da esperti di sport.