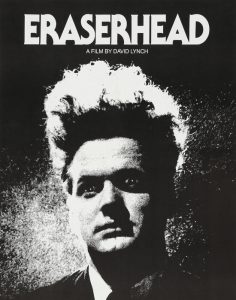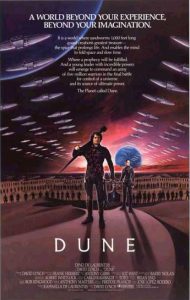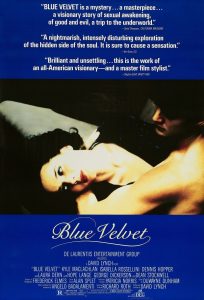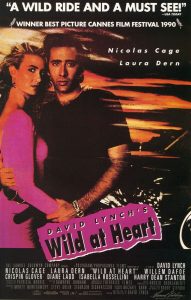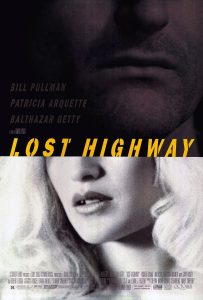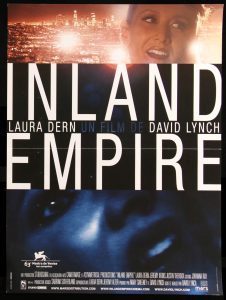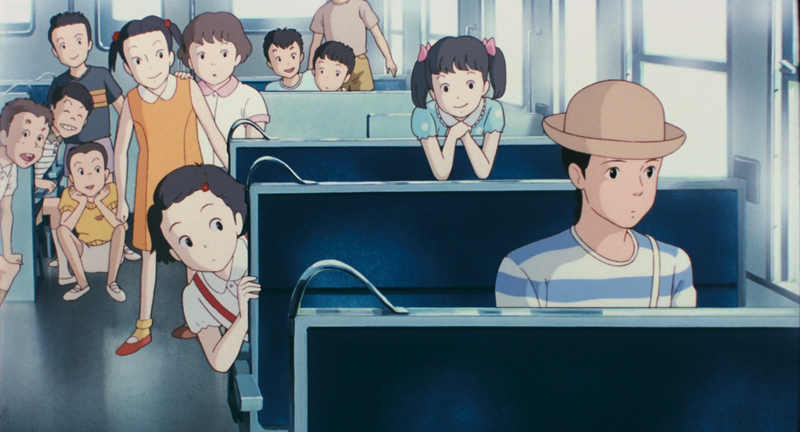Prodotto da Marvaso Production Films, il film — ormai giunto a fine riprese — vanta un cast ricco di volti noti e apprezzati dal pubblico italiano, tra cui: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Roncato, Isabella Adriani, Fioretta Mari, Anita Kravos, Raffaella Fico, Giuseppe Marvaso, Giorgia Fiori.
La regia è firmata da Mark Melville, con una sceneggiatura scritta da Marco Cassini, Domenico Helenio Marvaso (anche produttore) e Salvatore Romano. Il film si distingue per il ritmo dinamico e coinvolgente, dove azione, humor e continui colpi di scena si alternano tra i paesaggi mozzafiato della Costa degli Dèi, in Calabria. Le suggestive località di Tropea, Pizzo Calabro, Ricadi e Parghelia diventano il cuore visivo di una storia complessa, coraggiosa e interamente realizzata da una produzione indipendente.
All’interno di questo progetto, la Scuola di Recitazione della Calabria ha avuto un ruolo di primo piano, offrendo un contributo significativo sia nella ricerca di sponsor, sia nell’inserimento di numerosi talenti nel cast artistico.
Tra i partecipanti figurano, con ruoli e figurazioni: il fondatore e direttore Walter Cordopatri, l’allieva diplomata Federica Sottile e tutti gli allievi del Triennio Accademico:
Flavia Orecchio, Marco Aquino, Teresa Sorace, Enrica Iannelli, Valerio Diaco, Clarissa Severino.
A completare il cast anche gli allievi del corso laboratoriale: Angela Valensise, Caterina Borrello, Pasquale Vita, Federica Il Grande, Melissa Fiumara, Filippo Toscano, Giuseppe Ierace, Domenica Sorrenti, Rachele Gerace, Armando Giovinazzo, Salvador Cristarello.
Sempre attraverso i canali della SRC hanno dato il loro prezioso contributo numerose comparse, selezionate con cura e professionalità, che hanno saputo arricchire le scene del film con autenticità e vitalità.
Un sentito ringraziamento alla produzione Marvaso Production Films per aver condiviso con noi questo progetto nel quale crediamo fortemente e che, siamo certi, saprà appassionare il pubblico.
Per la Scuola di Recitazione della Calabria si tratta di una nuova conferma del proprio ruolo di riferimento nel panorama delle produzioni televisive, cinematografiche e teatrali: non solo un centro di formazione artistica d’eccellenza, ma anche una vera fucina di opportunità professionali concrete per i giovani attori/attrici e le nuove generazioni di interpreti.